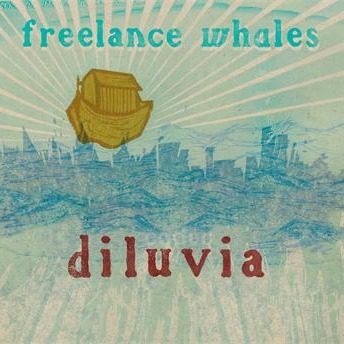Attraverso le sue cuffione plattan prese quella volta che è stato alla Rough Trade, Dio ha sentito l’ultimo dei Muse. E’ arrivato a Panic Station, e, incazzato nero, ha mandato un secondo diluvio. Questa volta però, ha lasciato che si salvassero solo le specie più lontane dall’antropomorfismo, in modo da avere almeno 10 miliardi di anni per chillarsi, prima che l’evoluzione possa portare a correre di nuovo il rischio che venga composta della musica di merda.
Questa è la probabile (ed implicita) premessa al secondo album dei Freelance Whales, Diluvia: il plurale di diluvium, il sequel di quella prima volta in cui Dio aveva deciso che anche basta; il miracolo di cui avremmo bisogno per salvarci dalla musica brutta.
I Freelance Whales sono cinque ragazzi del Queens, così indi da saper suonare banjo, mandolino e harmonium, e da aver cominciato esibendosi in metropolitana. A differenza della sopracitata produzione però, il loro disco è bello: già dall’opening ci rendiamo conto di essere di fronte ad un lavoro curatissimo, sviluppato con proprietà ed ispirazione. Dopo un breve intro di synth molto a luogo, compare un banjo, suonato in un modo che farebbe proprio incazzare i redneks che l’hanno inventato, ma che a noi piace tanto. Dopo un timido arpeggio, rullo di timpani: arriva la voce a riprendere una campionatura che già girava nell’aria, con una timbrica originale e molto ben miscelata con il resto.
Segue Land Features, che si apre con un altro arpeggio di banjo, subito seguito da una timida chitarrina elettrica e da synth molto ponderati. L’album fila via liscio, ben congegnato ed arrangiato, presentando un delicatissimo e raffinato mix di atmosfere acustiche, synth e campionature. Ogni tanto qualche contaminazione inaspettata: su Land Fatures come pure in Locked Out, che si aprono con un mood abbastanza consueto, sbucano dei fiati quasi free, così ben piazzati che, se li sentisse Paolo Fresu, diventerebbe subito indi e smetterebbe di essere sardo.
Valore aggiunto alle composizioni (già di per sé molto riuscite) viene conferito a questo disco dagli arrangiamenti: un precisissimo lavoro sulle dinamiche dei brani evita la noia, e miscela con ottimi risultati strumenti ed influenze con provenienze acustico-geografiche molto differenti tra loro. Nonostante sia nel complesso decisamente uniforme e non subisca bruschi cambiamenti di atmosfera, questo lavoro riesce a non annoiare quasi mai; gradevole al primo ascolto ed allo stesso tempo capace, con numerosissimi spunti, di offrire motivazioni per farne un secondo.
Anche se non siamo di fronte ad un lavoro di proporzioni bibliche, questo disco si fa ascoltare più che volentieri, presentando un ottimo compromesso tra indie folk e atmosfere ampie e ipnotiche, abbastanza vicine alle sonorità dei nostri fighissimi amici The xx.
Gli ascoltatori più convintamente etero sentiranno, dopo questo delicato ascolto, il bisogno di fare qualcosa da vero uomo per staccare un attimo, e andranno in Francia a rubare le divise da ferroviere insieme a Pete Doherty. Tuttavia, l’ essere etereo e sospeso, costituisce l’essenziale punto di forza di questo Diluvia, che riesce ad accattivare non poco.
Questo disco non è forse sufficiente a salvare le sorti del mondo (orbe terraquea e della discografia) e a garantirci che, per colpa di già citati Muse, il secondo diluvio prima o poi non avvenga davvero. È però sicuramente un buon lavoro, scorre con piacere, e, per 58 minuti, ci fa dimenticare la musica brutta.