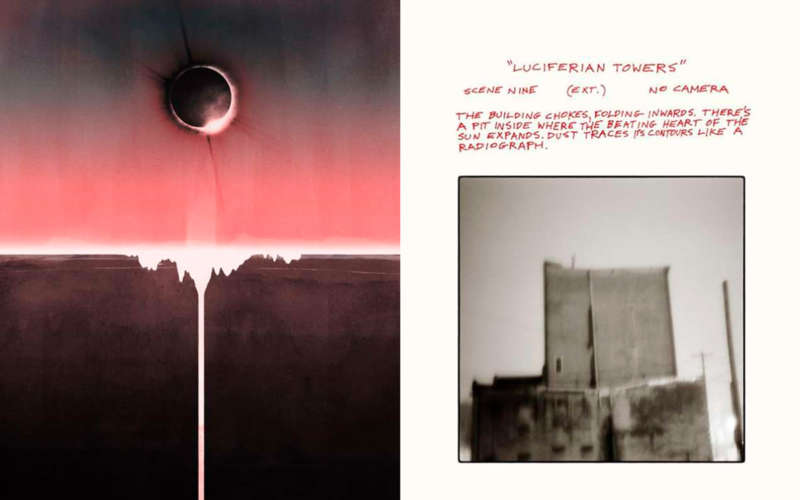Il post-rock è morto? Il post-rock sta morendo? È da qualche anno che, periodicamente, mi ritrovo a farmi questa domanda, e puntualmente lo faccio proprio quando sta per uscire un nuovo album post-rock. Forse succede perché non ne escono molti, forse perché l’attenzione data al genere sembra sempre più affievolirsi. Un’altra tesi accreditata è quella secondo cui il post-rock più classico, dopo la sperimentazione degli anni ’90 e l’affermazione dei 2000, si sia sempre più fossilizzato e abbia ormai poco da dire. E non è facile obiettare, vista l’assenza di nuovi nomi nella scena e l’interesse, nelle vecchie guardie come nelle nuove, a virare verso generi ibridi: solo l’anno scorso i Tortoise hanno rotto un silenzio discografico durato sette anni con The Catastrophist, un disco inaspettatamente cantato, mentre le nuove generazioni tendono a inquadrare il post-rock come genere sullo sfondo, mentre si è impegnati a fare emo, shoegaze o math rock. All’altro estremo ci sono band sempre fedeli a sé stesse – nel bene e nel male – come Explosions in the Sky, Hammock e Caspian. Nel mezzo ci sono gli instancabili Mogwai, che con Rave Tapes pescavano dall’elettronica ma che con le colonne sonore come Atomic e Les Revenants restavano in territori più familiari, e i Godspeed You! Black Emperor, che sono sempre stati un caso a sé stante, ma che in Asunder, Sweet and Other Distress avevano temporaneamente abbandonato i classici movimenti e field recording per lanciarsi in lunghi esperimenti drone.
Negli ultimi mesi sembra esserci una strana inversione di tendenza: a maggio esce, quasi in sordina, un nuovo album dei Do Make Say Think. La formazione canadese era sparita otto anni fa ma Stubborn Persistent Illusions è un grande ritorno a un post-rock potente e articolato grazie a una forte matrice jazz. È un disco di cui non si è parlato molto, ma che in un certo senso ha riaperto la stagione post-rock nel periodo più caldo dell’anno, che ha visto nuove uscite da parte dei Public Service Broadcasting e degli Hammock. Bisognava però attendere settembre per rivedere quelle che forse sono le due band di punta del genere, ai due estremi: Mogwai e Godspeed You! Black Emperor.
Mogwai – Every Country’s Sun

Atomic era stato una parziale delusione da parte dei Mogwai: non perché fosse un brutto album, ma perché non convinceva troppo la decisione di commercializzare una colonna sonora come un vero e proprio album, quando i fini con cui era stato prodotto erano inizialmente ben diversi. Every Country’s Sun è un ritorno ad un post-rock più Mogwai da parte della band scozzese, in cui i synth hanno un ruolo meno centrale che in Rave Tapes, e in cui le percussioni sorde rimangono al centro delle produzioni. I muri di suono e i crescendo riescono sempre ad adattarsi alle atmosfere create: che siano quelle più pop e cantate di Party in the Dark o quelle dei synth spaziali e disturbanti di aka 47 nella prima metà del disco, o quelle delle esplosioni di Don’t Believe the Fife o Battered at a Scramble nella seconda, più aggressiva metà. Every Country’s Sun è la scelta, da parte dei Mogwai, di archiviare parzialmente la sperimentazione per riposizionare e affinare ancora di più sound, atmosfere e tematiche, cristallizzandone la sinergia con grande attenzione.
Godspeed You! Black Emperor – Luciferian Towers
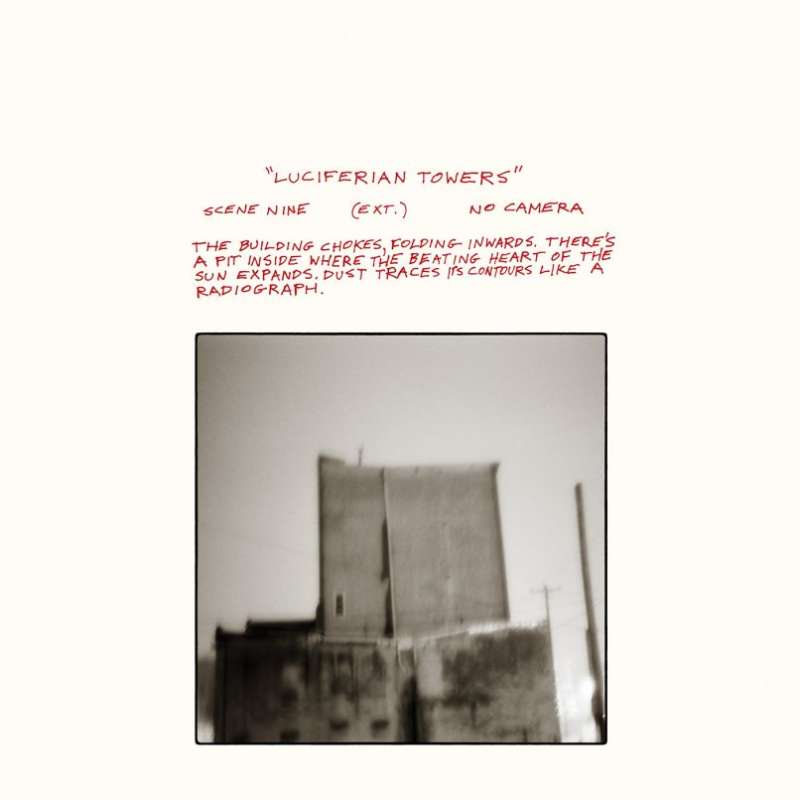 I brani cardine di Luciferian Towers i Godpseed You! Black Emperor li suonano in tour dal 2015. Non è stata una grossa sopresa quindi ritrovare Bosses Hang e Anthem for No State all’interno dell’album, spezzettati in tre movimenti ciascuno come da tradizione per il collettivo canadese. Mancano anche qui, come in Asunder, Sweet and Other Distress, i sample e field recording di F#A# Infinity e Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, ma la volontà di creare atmosfere disturbanti, esasperanti ed apocalittiche è indiscutibile nelle produzioni così come nel comunicato stampa che accompagna il disco (che descrive il Canada come “a crippled thing, drowning in a puddle, covered in ants“). Undoing a Luciferian Towers è un lungo intro dissonante da cui il motivo centrale emerge gradualmente, per venire poi ripreso nel cuore dell’album da Fam/Famine, in cui viene annegato in muri di suono dissonanti, espressioni del massimalismo come forza motrice e simbolo del caos. Bosses Hang, una cavalcata epica di 15 minuti, porta in prima fila il noise stridente delle chitarre ma il motivo al cuore è quello del violino di Sophie Trudeau. Anthem for No State, infine, è un compendio alla realizzazione della rivolta auspicata da Luciferian Towers, e come tutti i mot(t)i di conquista esplode in tutta la sua epicità nel terzo movimento, non prima di aver dato spazio ad un accenno di speranza e luminosità nel sound più sparuto dei primi due movimenti. Sta all’ascoltatore il compito di interpretarlo come barlume di ottimismo o utopia ormai rassegnata, ma è indubbio il talento dei GY!BE nell’abbracciare luci ed ombre in una dualità interessante proprio perché costantemente ambigua. Ed è anche grazie anche ad un parziale rimando ai primi lavori che Luciferian Towers è forse il loro disco migliore post-reunion.
I brani cardine di Luciferian Towers i Godpseed You! Black Emperor li suonano in tour dal 2015. Non è stata una grossa sopresa quindi ritrovare Bosses Hang e Anthem for No State all’interno dell’album, spezzettati in tre movimenti ciascuno come da tradizione per il collettivo canadese. Mancano anche qui, come in Asunder, Sweet and Other Distress, i sample e field recording di F#A# Infinity e Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, ma la volontà di creare atmosfere disturbanti, esasperanti ed apocalittiche è indiscutibile nelle produzioni così come nel comunicato stampa che accompagna il disco (che descrive il Canada come “a crippled thing, drowning in a puddle, covered in ants“). Undoing a Luciferian Towers è un lungo intro dissonante da cui il motivo centrale emerge gradualmente, per venire poi ripreso nel cuore dell’album da Fam/Famine, in cui viene annegato in muri di suono dissonanti, espressioni del massimalismo come forza motrice e simbolo del caos. Bosses Hang, una cavalcata epica di 15 minuti, porta in prima fila il noise stridente delle chitarre ma il motivo al cuore è quello del violino di Sophie Trudeau. Anthem for No State, infine, è un compendio alla realizzazione della rivolta auspicata da Luciferian Towers, e come tutti i mot(t)i di conquista esplode in tutta la sua epicità nel terzo movimento, non prima di aver dato spazio ad un accenno di speranza e luminosità nel sound più sparuto dei primi due movimenti. Sta all’ascoltatore il compito di interpretarlo come barlume di ottimismo o utopia ormai rassegnata, ma è indubbio il talento dei GY!BE nell’abbracciare luci ed ombre in una dualità interessante proprio perché costantemente ambigua. Ed è anche grazie anche ad un parziale rimando ai primi lavori che Luciferian Towers è forse il loro disco migliore post-reunion.