Oggi vi raccontiamo otto bei dischi che non dovete perdervi. Molti feels, ma non solo.
BROCKHAMPTON – iridescence
 Una decina di ragazzi americani nella metà dei vent’anni, gli USA, il rap, un contratto con la Sony, una piccola gemma. Sì, iridescence è un gioiellino contemporaneo, un opuscolo orientativo di ciò che il rap dovrebbe essere oggi: vivo, crudo, sincero, poliedrico e sfaccettato. L’etichetta di “boy band” che tanto viene usata per descriverli, così come anche il concetto stesso di “rap” nel senso più riduttivo e scontato del termine, stanno stretti ai BROCKHAMPTON, e basta ascoltare il disco per capirlo. Momenti riflessivi si alternano a ira violenta, basi minimali ad altre più orchestrali, bassi ruvidi a melodie delicate, strumenti analogici ad autotune, bum bap, soul, pop, jungle, rock, elettronica avanguardista. La band prende tutto il positivo dell’essere un collettivo, esaltando sì le doti individuali di ciascuno, ma soprattutto tenendo il lavoro unito da un fil rouge, riuscendo a creare un album che trasuda talento e che scorre liscio, raccontando una storia che non annoia mai e che, alla fine, insegna qualcosa (provate a non commuovervi con SAN MARCOS e TONYA). Considerando anche che iridescence è il primo capitolo di una trilogia più ampia dall’eloquente titolo The Best Years Of Our Lives, non possiamo fare altro che volerne di più. Sono tempi duri, sembra tutto un disastro, il futuro fa paura, ma, vissuti insieme, sono i migliori anni della nostra vita.
Una decina di ragazzi americani nella metà dei vent’anni, gli USA, il rap, un contratto con la Sony, una piccola gemma. Sì, iridescence è un gioiellino contemporaneo, un opuscolo orientativo di ciò che il rap dovrebbe essere oggi: vivo, crudo, sincero, poliedrico e sfaccettato. L’etichetta di “boy band” che tanto viene usata per descriverli, così come anche il concetto stesso di “rap” nel senso più riduttivo e scontato del termine, stanno stretti ai BROCKHAMPTON, e basta ascoltare il disco per capirlo. Momenti riflessivi si alternano a ira violenta, basi minimali ad altre più orchestrali, bassi ruvidi a melodie delicate, strumenti analogici ad autotune, bum bap, soul, pop, jungle, rock, elettronica avanguardista. La band prende tutto il positivo dell’essere un collettivo, esaltando sì le doti individuali di ciascuno, ma soprattutto tenendo il lavoro unito da un fil rouge, riuscendo a creare un album che trasuda talento e che scorre liscio, raccontando una storia che non annoia mai e che, alla fine, insegna qualcosa (provate a non commuovervi con SAN MARCOS e TONYA). Considerando anche che iridescence è il primo capitolo di una trilogia più ampia dall’eloquente titolo The Best Years Of Our Lives, non possiamo fare altro che volerne di più. Sono tempi duri, sembra tutto un disastro, il futuro fa paura, ma, vissuti insieme, sono i migliori anni della nostra vita.
Voto: 8.1 – Simone Zagari
Julia Holter – Aviary
 Presentato come il suono della “cacofonia della mente in un mondo sull’orlo del collasso”, il quinto album in studio di Julia Holter si rivela come il perfetto compagno di viaggio per questi tempi tormentati. Un’ora e mezza di durata, 15 brani, la maggior parte di essi abbondantemente oltre i 5 minuti, la sensazione di disagio che accompagna lo sferragliare dell’iniziale Turn The Light On, lo smarrimento davanti alla prepotente presa di distanza dalle atmosfere di Have You In My Wilderness. L’improvvisa apertura pop di Whether non deve trarre in inganno: Aviary è un disco che vive di pieni e di vuoti, di rumore e calma piatta, capace di scivolare da ballate piano e voce a momenti da musical in tutta la loro grandeur. È anche difficile consigliare singoli brani in un album che va ascoltato tutto d’un fiato (pistola alla tempia? L’ipnotica Voce Simul e il saliscendi emotivo I Would Rather See) e che racconta alla perfezione la confusione del nostro presente.
Presentato come il suono della “cacofonia della mente in un mondo sull’orlo del collasso”, il quinto album in studio di Julia Holter si rivela come il perfetto compagno di viaggio per questi tempi tormentati. Un’ora e mezza di durata, 15 brani, la maggior parte di essi abbondantemente oltre i 5 minuti, la sensazione di disagio che accompagna lo sferragliare dell’iniziale Turn The Light On, lo smarrimento davanti alla prepotente presa di distanza dalle atmosfere di Have You In My Wilderness. L’improvvisa apertura pop di Whether non deve trarre in inganno: Aviary è un disco che vive di pieni e di vuoti, di rumore e calma piatta, capace di scivolare da ballate piano e voce a momenti da musical in tutta la loro grandeur. È anche difficile consigliare singoli brani in un album che va ascoltato tutto d’un fiato (pistola alla tempia? L’ipnotica Voce Simul e il saliscendi emotivo I Would Rather See) e che racconta alla perfezione la confusione del nostro presente.
“Who draws the circles? Who made this mappa? I see no beginning / No middle / No end”
Voto: 7.8 – Sebastiano Orgnacco
Cloud Nothings – Last Building Burning
Assistere a un live dei Cloud Nothings è un’esperienza distruttiva, in cui i ritmi sono accelerati, i ritornelli sono rabbiosi e violenti, e né il pubblico né la batteria di Jayson Gerycz hanno tempo per riprendere fiato; questo spiega la presenza di brani più docili sparsi nella loro discografia, e più presenti in Life Without Sound (2017). Ma il talento dei Cloud Nothings ha sempre brillato nelle esplosioni post-hardcore e noise di brani sporchi e lunghi come Wasted Days e Pattern Walks, e molti di noi avrebbero desiderato un album senza ‘pause’, belle che fossero. E con Last Building Burning Dylan Baldi fa il passo più coraggioso per una band dal pubblico crescente: esasperare i ritmi e le distorsioni, sporcare la produzione, cancellare dalla voce ogni traccia di velleità pop. Il risultato è un album che si esplode tutto d’un fiato, trascinato dalle pelli instancabili di Gerycz e le cui influenze si allontanano dall’indie rock e tornano alle radici dei Fugazi, dei Drive Like Jehu e più vicine ai colleghi Metz, conservando intatto il talento di Baldi alla scrittura. Last Building Burning è un disco che non vediamo l’ora ci distrugga dal vivo.
Voto: 7.7 – Claudia Viggiano
boygenius – boygenius EP
 In un mondo giusto, Lucy Dacus (1995), Julien Baker (1995) e Phoebe Bridgers (1994) sarebbero le voci di una generazione. boygenius, il progetto che le vede formalmente insieme per la prima volta – in realtà le tre si sono incrociate spesso nei rispettivi tour e si conoscono (e piacciono) da anni – è un diario letto a voce alta. Abituati come siamo al discorso ironico, al cinismo soft-core e ad esorcizzare la realtà con i meme, le sei tracce di boygenius arrivano come un pugno allo stomaco perché sono un’esplosione emotiva, e chi parla con coraggio di sentimenti nudi e crudi, oggi, spiazza. I fan riconosceranno sicuramente le chitarre più sfrontate della Dacus (Bite The Hand), la spiritualità e l’attitudine emo della Baker (Stay Down) e le atmosfere intimiste à la Elliot Smith di Phoebe Bridgers, ma il gruppo è più della somma delle sue parti. “They’re all sad, but this one’s especially sad”: così qualche tempo fa la Bridgers ha introdotto un suo pezzo, durante un concerto ad Asbury Lanes, in New Jersey. Il messaggio di boygenius è proprio questo: mollate un po’ la presa ragazzi, che va bene anche essere tristi, va bene anche essere seri, va bene – udite udite – provare qualcosa.
In un mondo giusto, Lucy Dacus (1995), Julien Baker (1995) e Phoebe Bridgers (1994) sarebbero le voci di una generazione. boygenius, il progetto che le vede formalmente insieme per la prima volta – in realtà le tre si sono incrociate spesso nei rispettivi tour e si conoscono (e piacciono) da anni – è un diario letto a voce alta. Abituati come siamo al discorso ironico, al cinismo soft-core e ad esorcizzare la realtà con i meme, le sei tracce di boygenius arrivano come un pugno allo stomaco perché sono un’esplosione emotiva, e chi parla con coraggio di sentimenti nudi e crudi, oggi, spiazza. I fan riconosceranno sicuramente le chitarre più sfrontate della Dacus (Bite The Hand), la spiritualità e l’attitudine emo della Baker (Stay Down) e le atmosfere intimiste à la Elliot Smith di Phoebe Bridgers, ma il gruppo è più della somma delle sue parti. “They’re all sad, but this one’s especially sad”: così qualche tempo fa la Bridgers ha introdotto un suo pezzo, durante un concerto ad Asbury Lanes, in New Jersey. Il messaggio di boygenius è proprio questo: mollate un po’ la presa ragazzi, che va bene anche essere tristi, va bene anche essere seri, va bene – udite udite – provare qualcosa.
Voto: 7.9 – Ilaria Procopio
Big Red Machine – Big Red Machine
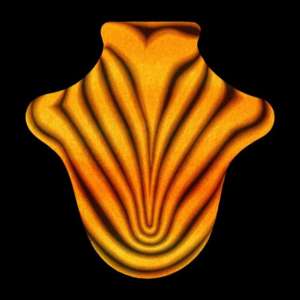 Prendi Justin Vernon aka Bon Iver, prendi Aaron Dessner aka uno dei due che suona la chitarra nei National, aggiungici qualche collaborazione (Phoebe Bridgers e Arcade Fire), mescola con cura e ottieni i Big Red Machine. In realtà è molto più complesso di così. Nel self titled si intersecano le due anime degli amici che formano il progetto: Vernon apporta la sua voce, le derive di elettronica sghemba che tanto hanno caratterizzato il suo ultimo 22, A Million, e anche la sua militanza nei Volcano Choir; Dessner costruisce erudite intessiture melodiche, spezzandole con arpeggi di chitarra incompiuti e graffianti o con accordi di piano rassicuranti. Per chi mastica i due/tre progetti originari, dunque, nulla di nuovo sotto il sole e anzi, talvolta i due sembrano perdersi per strada, chiudendosi a spirale in una formula fissa e quasi auto-imposta, limitante. Il disco si rivela, però, quando i due geni dispiegano liberi le ali, dimentichi di sovrastrutture, perdendosi appositamente e ritrovandosi nel percorso, partorendo piccole gemme che sono piacevolissime compagne di questo 2018 musicale (Gratitude, Lyla, People Lullaby, Melt). Ci aspettavamo qualcosa di più, sì, ma quando andavo in sala prove a cazzeggiare con gli amici non scrivevo mica dischi del genere.
Prendi Justin Vernon aka Bon Iver, prendi Aaron Dessner aka uno dei due che suona la chitarra nei National, aggiungici qualche collaborazione (Phoebe Bridgers e Arcade Fire), mescola con cura e ottieni i Big Red Machine. In realtà è molto più complesso di così. Nel self titled si intersecano le due anime degli amici che formano il progetto: Vernon apporta la sua voce, le derive di elettronica sghemba che tanto hanno caratterizzato il suo ultimo 22, A Million, e anche la sua militanza nei Volcano Choir; Dessner costruisce erudite intessiture melodiche, spezzandole con arpeggi di chitarra incompiuti e graffianti o con accordi di piano rassicuranti. Per chi mastica i due/tre progetti originari, dunque, nulla di nuovo sotto il sole e anzi, talvolta i due sembrano perdersi per strada, chiudendosi a spirale in una formula fissa e quasi auto-imposta, limitante. Il disco si rivela, però, quando i due geni dispiegano liberi le ali, dimentichi di sovrastrutture, perdendosi appositamente e ritrovandosi nel percorso, partorendo piccole gemme che sono piacevolissime compagne di questo 2018 musicale (Gratitude, Lyla, People Lullaby, Melt). Ci aspettavamo qualcosa di più, sì, ma quando andavo in sala prove a cazzeggiare con gli amici non scrivevo mica dischi del genere.
Voto: 7.1 – Simone Zagari
Kurt Vile – Bottle It In
 Kurt Vile non è un semplice cantautore, Kurt Vile is a state of mind. Dici Kurt Vile e pensi ad atmosfere Seventies, all’eredità di Dylan e Neil Young, ai road trip in Volkswagen e ai viaggi mentali, ai capelli selvaggi e ai Levis slavati. In Bottle It In, che arriva a tre anni di distanza dal’acclamato B’lieve I’m Goin’ Down, non c’è niente di catchy, né c’è una Pretty Pimpin a fare da singolone. Tutto è lento, naif e anacronistico: 79 minuti – un azzardo rispetto alle logiche frenetiche e usa-e-getta che impone il mercato – per restare ancora una volta imbambolati dalle sue chitarre pigre (Skinny Mini) e sognanti (Cold Was The Wind), giocherellone (Yeah Bones) o country (Rollin’ With The Flow). Bassackward, secondo singolo estratto dal disco, rappresenta alla perfezione l’universo mondo di Kurt Vile, capace di spezzare i cuori e contemporaneamente di strappare un sorriso, spesso anche in una stessa strofa (“I was on the ground but looking straight into the sun / But the sun went down and I couldn’t find another one”). Il rischio è uno solo ed è sempre quello: sembrare alla lunga un po’ ripetitivo e fuori dal tempo, come un ragazzo che per strada allunga le copie di “Lotta Comunista”.
Kurt Vile non è un semplice cantautore, Kurt Vile is a state of mind. Dici Kurt Vile e pensi ad atmosfere Seventies, all’eredità di Dylan e Neil Young, ai road trip in Volkswagen e ai viaggi mentali, ai capelli selvaggi e ai Levis slavati. In Bottle It In, che arriva a tre anni di distanza dal’acclamato B’lieve I’m Goin’ Down, non c’è niente di catchy, né c’è una Pretty Pimpin a fare da singolone. Tutto è lento, naif e anacronistico: 79 minuti – un azzardo rispetto alle logiche frenetiche e usa-e-getta che impone il mercato – per restare ancora una volta imbambolati dalle sue chitarre pigre (Skinny Mini) e sognanti (Cold Was The Wind), giocherellone (Yeah Bones) o country (Rollin’ With The Flow). Bassackward, secondo singolo estratto dal disco, rappresenta alla perfezione l’universo mondo di Kurt Vile, capace di spezzare i cuori e contemporaneamente di strappare un sorriso, spesso anche in una stessa strofa (“I was on the ground but looking straight into the sun / But the sun went down and I couldn’t find another one”). Il rischio è uno solo ed è sempre quello: sembrare alla lunga un po’ ripetitivo e fuori dal tempo, come un ragazzo che per strada allunga le copie di “Lotta Comunista”.
Voto: 7.0 – Ilaria Procopio
Pinegrove – Skylight
 Skylight, il secondo album dei Pinegrove, archivia una vicenda turbolenta e parzialmente distorta riguardante il frontman Evan Stephens Hall. Dopo un anno di pausa band torna a far parlare di sé musicalmente, promettendo di donare tutti i profitti dell’album in beneficenza. I Pinegrove sono tra quelle band che ad un paio di ascolti ti scorrono davanti come qualcosa di piacevole, finché non ti ricapitano sottomano e non ti travolgono in un abbraccio confortevole, sicuro. È quello che era successo con Cardinal e che succede anche con Skylight: le melodie sono familiari ma calde, espressive, nuove; la penna di Hall racconta di esperienze semplici ma uniche, umane, e per questo emozionanti. È la descrizione più adatta per la musica dei Pinegrove: una musica semplice, in fondo, fatta da esseri umani.
Skylight, il secondo album dei Pinegrove, archivia una vicenda turbolenta e parzialmente distorta riguardante il frontman Evan Stephens Hall. Dopo un anno di pausa band torna a far parlare di sé musicalmente, promettendo di donare tutti i profitti dell’album in beneficenza. I Pinegrove sono tra quelle band che ad un paio di ascolti ti scorrono davanti come qualcosa di piacevole, finché non ti ricapitano sottomano e non ti travolgono in un abbraccio confortevole, sicuro. È quello che era successo con Cardinal e che succede anche con Skylight: le melodie sono familiari ma calde, espressive, nuove; la penna di Hall racconta di esperienze semplici ma uniche, umane, e per questo emozionanti. È la descrizione più adatta per la musica dei Pinegrove: una musica semplice, in fondo, fatta da esseri umani.
Voto: 7.3 – Claudia Viggiano
Empress Of – Us
 È con il suo Us che Empress Of decide di lasciare da parte le opinioni del mondo esterno, precisando in varie interviste che ormai non le importa più niente di apparire. Vuole solo lavorare ad ogni piccolo aspetto della propria arte, producendone anche gran parte con l’aiuto di diverse persone a lei care, mettendo in buona luce, oltre la propria individuale natura, anche le qualità della sua cerchia di amici (Dev Hynes, DJDS, Georgia, Pional e Chrome Sparks). Questa idea di unità, nata dopo il ritorno a Los Angeles da New York, scaturisce in gran parte per l’affezione alla radice latina della propria famiglia, riversandosi nell’utilizzo dello spagnolo per alcuni testi e quindi la voglia di poter esprimere concetti intimi nella propria lingua. La ricchezza di suoni, poi, offre diversi scenari: dalla caduta libera di ritmi trip-hop sulla nuova scuola rnb (Everything To Me), ad upbeat caraibici (Just The Same, I Don’t Even Smoke Weed) e toni cloud (I’ve Got Love). Che poi lo si voglia descrivere come un lavoro elctro-pop o pop che sia, Us va oltre le aspettative “catchy” di quello che per molti potrebbe giungere ad essere un ascolto disinteressato, offrendo molto più.
È con il suo Us che Empress Of decide di lasciare da parte le opinioni del mondo esterno, precisando in varie interviste che ormai non le importa più niente di apparire. Vuole solo lavorare ad ogni piccolo aspetto della propria arte, producendone anche gran parte con l’aiuto di diverse persone a lei care, mettendo in buona luce, oltre la propria individuale natura, anche le qualità della sua cerchia di amici (Dev Hynes, DJDS, Georgia, Pional e Chrome Sparks). Questa idea di unità, nata dopo il ritorno a Los Angeles da New York, scaturisce in gran parte per l’affezione alla radice latina della propria famiglia, riversandosi nell’utilizzo dello spagnolo per alcuni testi e quindi la voglia di poter esprimere concetti intimi nella propria lingua. La ricchezza di suoni, poi, offre diversi scenari: dalla caduta libera di ritmi trip-hop sulla nuova scuola rnb (Everything To Me), ad upbeat caraibici (Just The Same, I Don’t Even Smoke Weed) e toni cloud (I’ve Got Love). Che poi lo si voglia descrivere come un lavoro elctro-pop o pop che sia, Us va oltre le aspettative “catchy” di quello che per molti potrebbe giungere ad essere un ascolto disinteressato, offrendo molto più.
Voto: 7.0 – Claudio Carboni














