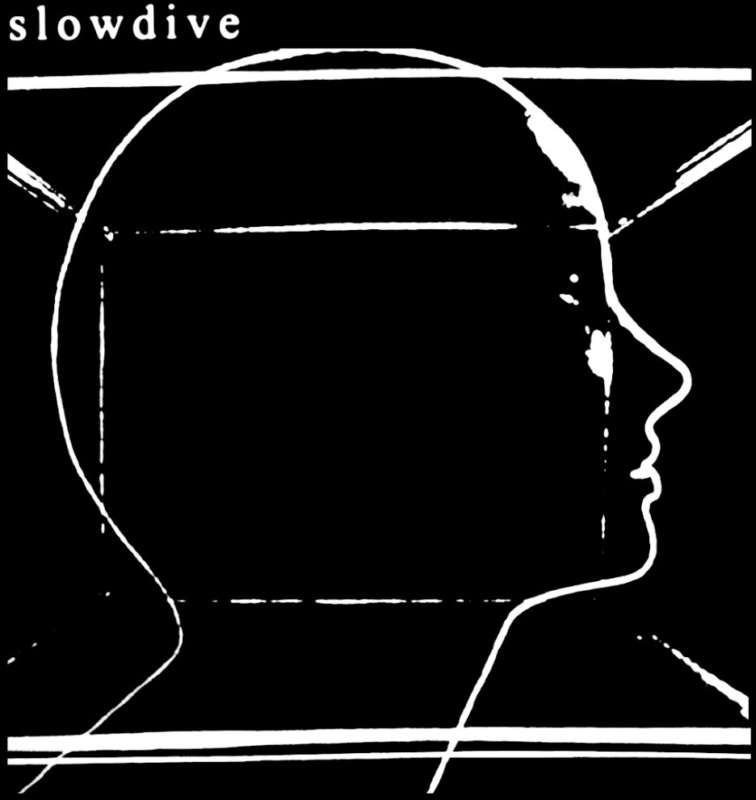Era il 2014 quando in occasione del Primavera Sound Festival una Rachel Goswell visibilmente emozionata saliva sul palco a sancire il ritorno degli Slowdive, la cui lezione si era dimostrata decisamente meno transitoria di quanto si sarebbe potuto immaginare stando agli effettivi anni di attività, che coprivano a malapena la prima metà degli anni ’90. L’ultimo degli shoegaze revival era iniziato da poco (appena un anno prima c’era stato il ritorno dei My Blood Valentine con m b v) e si dimostrava un fenomeno singolare, perchè oltre a generare nuovi progetti più o meno debitori al genere si era tradotto anche in una specie di chiamata alle armi per gli artisti che avevano iniziato a disciogliere chitarre in un liquido amniotico di riverberi e inquietudine: un cambio generazionale che procedeva in parallelo con alcune resurrezioni significative e spesso totalmente insperate.
Dopo il rodaggio in tour, il quintetto di Reading non avrebbe potuto esimersi dal fare il passo successivo e contribuire al nuovo capitolo tornando in studio, affrontando un contesto musicale fatto di tante coordinate in più. Decine di formazioni negli anni 2000 si erano preoccupate di personalizzare la propensione per le trame di corde ad alta densità, o avevano dato una forma compiuta a derive meno ortodosse e messa da parte la celebrazione delle chitarre avevano abusato delle componenti sintetiche – qualcuno collocò il tutto nello stesso calderone e lo chiamò nu gaze. Non solo: in loro assenza la musica aveva attraversato la più drastica delle rivoluzioni, ossia l’avvento del web. Se ad accogliere Rachel e sodali sotto il Sony Stage c’erano anche molti nuovi seguaci, estasiati quanto quelli della prima ora, lo si doveva soprattutto ai social network che avevano stravolto le dinamiche promozionali e alla facilità nell’entrare in contatto con la musica del passato mediante contenitori come YouTube.
Insomma, a voler soppesare un’ondata revivalista e discernere un potenziale fermento da sterili attitudini decadenti non c’è occasione migliore di quella offerta dai pionieri che decidono di misurarsi con l’attualità.
Trascorsi 22 anni dall’ultimo full-length prima dello scioglimento (Pygmalion, quello su cui un inquieto Neil Halstead finì per calcare troppo e con entrambe le mani, quella dark folk e quella sperimentale) oggi la line-up è la stessa di allora, con i membri dell’esordio e Simon Scott alla batteria, ma l’età anagrafica e le esperienze che nel mentre ognuno ha affrontato lontano dagli altri devono aver senz’altro contribuito a far sì che gli Slowdive nel nuovo millennio non abbiano dovuto fare i conti con protagonismi o contrasti in fatto di esigenze espressive. Le attività collaterali di Neil e Rachel devono aver inoculato nuova linfa vitale al processo compositivo, ma d’altro canto la levità delle otto tracce di Slowdive ricalca l’umore di Just for a Day, l’intenso esordio deliziosamente acerbo che nel ’91 NME descriveva come ideale punto di raccordo tra Cocteau Twins e Mudhoney. E così la sostanza del disco con cui il quintetto di Reading si presenta oggi è un fil rouge che congiunge gli albori al momento contingente, un lavoro significativamente eponimo come il primissimo EP ma che – nel bene e nel male – si rivela perfettamente coniugato al presente.
Gli ingredienti base ci sono tutti – delay, corde languide, walls of sound, vocals eterei – ma meticciati e mitigati. Lo space rock di Slomo inaugura l’ascolto con percussioni ovattate e un giro circolare di chitarra annegato nei feedback, una linea che ammicca a quella di Crazy For You ma la struttura melodica non è altrettanto ardita e non degenera in loop stranianti, con la voce liquefatta di Neil che si fonde con i back vocals di Rachel e riequilibra il rapporto voce-suono: è un aspetto che ricorre in tutto il disco e che lo allontana dallo shoegaze seminale in cui il cantato soccombeva sotto il peso dell’apparato strumentale moltiplicato dagli effetti. In assenza di elementi in qualche modo dispotici, il risultato complessivo è omogeneo, decisamente più orientato al pop e propenso alle contaminazioni. Star Roving è più robusta sin dall’intro e procede a ritmo sostenuto sovrastando i ronzii, ma ancora una volta, seppur screziata dai riverberi, la voce di Halstead è netta e le proporzioni insolite devono qualcosa alla corposa miscela di shoegaze e post-metal degli Alcest di Shelter, l’album a cui Neil contribuì con un featuring. Il consueto sound a tinte fosche di Sugar for the Pill possiede la morbidezza dell’alt country à la Mojave 3. La nuvola di chitarre di Everyone Knows e la sezione ritmica più secca su cui si srotola il falsetto della Goswell creano un episodio simile ad alcuni di quelli dell’eponimo debutto dei Minor Victories in cui Rachel milita dallo scorso anno.
Non sono però solamente i progetti vissuti in prima persona ad essersi innestati nel sound della band. Ascolto dopo ascolto, Slowdive si rivela un lavoro ben conscio delle tendenze in atto nel contesto entro cui vuole collocarsi. A voler scomporre alcuni brani in fattori primi, questi si rivelano melange riuscitissimi di elementi contemporanei, su cui poi gli effetti consueti e il cantato estatico di Rachel provvedono ad apporre il marchio “Slowdive”. Come accade in Don’t Know Why: le percussioni decise e le chitarre hanno un sapore quasi surf, che se non fosse per le sbavature potrebbero dirsi suonate dai Real Estate, la psichedelia soft è quella delle melodie adulterate dei DIIV, la mandola dopo il refrain ricorda il sadcore à la Sun Kil Moon ma è dilatata a dovere.
Decisamente meno prevedibili invece sono gli esiti dei due brani che concludono il lotto. Su un fondale disturbato, Go Get It rompe gli schemi muovendosi in direzione post rock, con le percussioni che le conferiscono un incedere volubile, come il pulsare di un’incandescenza sotto la cenere che poi divampa nei ritornelli. Falling Ashes, otto minuti abbondanti di piano tintinnante, è una nenia vagamente orientale sul cui si accomoda il cantato carezzevole e simbiotico di Neil e Rachel.
In sostanza, restano intatti almeno un paio degli elementi essenziali e pregevoli degli Slowdive, che potrebbero giustificare tutti i compromessi di cui questo disco è fatto. Innanzitutto la fisicità del suono, che è sempre negata, diluita in stratificazioni molteplici e impalpabili, e che senza dubbio si apprezza meglio in cuffia (così come dal vivo il sound degli Slowdive è penalizzato sugli stage all’aperto, perchè in qualche modo è sempre il bozzolo il loro habitat naturale). In secondo luogo, la filosofia di quella che all’epoca chiamarono “The Scene That Celebrates Itself“: se gli Slowdive di oggi rivelano l’influenza di artisti che sono stati da loro stessi all’epoca influenzati, il processo è figlio legittimo del cameratismo di quelle band con lo sguardo rivolto verso il basso che gli valse il nome di shoegazer, tra le quali collaborare e contaminarsi era la (sana?) prassi.
Slowdive non possiede la veemenza necessaria a rimettere le carte in gioco e dettare nuove linee guida del genere – che inevitabilmente è quello che si pretende ogni volta che ad esprimersi sono i maestri – ma piuttosto racconta il fervore sommesso di una scena che se non si è ancora esaurita forse lo deve proprio al fatto che non ha mai amato le svolte drastiche.
Tracce consigliate: Don’t Know Why, Go Get It