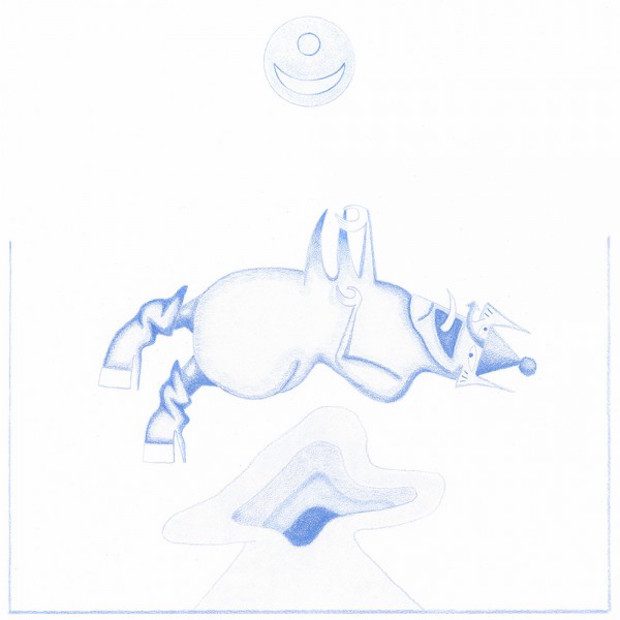Il lato buono dell’America è fatto di individui come Devendra Banhart, incastri fortuiti e irripetibili di culture col bisogno di tradursi in arte. A tre anni da Mala il gusto del pupillo di Michael Gira nel flirtare con le contraddizioni per convertirle in armonia è lo stesso, ma gli esiti di Ape in Pink Marble prendono le distanze dalle stravaganze affascinanti del passato e dalle speculazioni in quello sconfinato contenitore che è il folk a stelle e strisce. A un primo ascolto, a vederlo mitigare le sue riletture eccentriche, verrebbe da dire che il passo sia stato fatto all’indietro, ma in realtà il nuovo è un capitolo si lascia apprezzare un po’ alla volta, finché appare chiaro che il superamento dei manierismi è stato un processo naturale e necessario per confezionare tre quarti d’ora sommessi e cullanti. La retromania si è fatta discreta e si esprime nei dettagli, impreziosisce gli arrangiamenti e lascia alle liriche il respiro più ampio. La serenità delle tredici tracce di questo nono album in studio è quella di chi sa farsi ascoltare senza ricorrere ad astuzie chiassose, affidando tutto alla confortante estemporaneità che da sempre caratterizza le composizioni del cantautore statunitense.
Mentre il suo predecessore ruota tutto intorno a Devendra, lo sguardo di Ape in Pink Marble vaga libero con la sua poetica lunatica. La dedica sulla prima pagina del libro è per ricordare un amico che non c’è più, Asa Ferry dei Kind Hearts and Coronets, e la nostalgia sintetica dell’opener Middle Names passa anche per le linee vocali incerte, perchè il tono è quello di chi parla col cuore in mano. Jon Lends a Hand, è un tributo schietto che omaggia la musica dell’ex Modern Lovers Jonathan Richman prendendone in prestito gli accordi. Il ronzio discreto del synth di Linda ad emulare un sax condensa in note tutta la solitudine della donna di cui narra. “There’s no one in the world that I love / And that no one is you“, una donna orientale vestita di verde inspira una canzone d’amore tenera e bizzarra (Theme for a Taiwanese woman in lime green). Il risultato è slegato, sì, ma che importa? Per Banhart l’incoerenza è sempre stata una virtù di cui far sfoggio più che un passo falso da evitare.
Le sonorità innestano psichedelia misurata e fascinazioni provenienti dall’estremo Oriente, a generare frutti dolci e maturi, gli esotismi demodè che si afflosciano come il suono che esce da un mangianastri con le pile scariche in Good Time Charlie, o quelli nelle corde di koto pizzicate sul punteggiare imperfetto dei beat di Saturday Night. Le prove in territori 70s producono ancora qualche episodio lo-fi e scanzonato nel tintinnare funky di Fancy Man, che esordisce in arpeggi folk rinnegati dopo pochi secondi da un’imprevedibile attitudine soul, a condensare tutta la volubilità gioiosa di cui Banhart è capace, ma qui l’adorabile sfrontatezza del passato sa farsi estrema delicatezza, e in pochi minuti dalle atmosfere lynchiane del synth solenne di Mourner’s Dance si naviga senza alcuna fatica verso una ballad sghemba come Lucky e la placidità mistica di Celebration.
Un album sussurrato, per cui inevitabilmente meno catchy rispetto ai lavori che hanno generato tutto il freak folk dell’ultimo decennio, ma che probabilmente volta la pagina al momento giusto, prima che nel termine “freak” Devendra ci resti intrappolato: Ape in Pink Marble è una seduta di meditazione da affrontare con occhi puliti, dimenticandosi di chi si è stati, celebrando le contraddizioni umane e l’imprevisto.
Tracce consigliate: Middle Names, Lucky