Clay Jensen ha 17 anni. La stessa età di Hannah Baker quando decide di ammazzarsi tagliandosi le vene nella vasca da bagno di casa dei suoi. Prima di farlo, Hannah incide con un registratore a cassetta 13 nastri. In ciascuno articola una ragione per cui si è tolta la vita.
13 (nell’originale 13 Reasons Why) è una serie rilasciata il 31 marzo in esclusiva in tutti i paesi serviti da Netflix. È tratta da un romanzo che rientra in quella strana categoria letteraria per cui usiamo l’etichetta “Young Adult Fiction” che comprende la saga di Twilight, i libri di John Green (Paper Towns con Cara Delevingne?), ma pure, per dire, Piccole Donne.
La serie è un po’ Dawson’s Creek e i suoi adolescenti verbosi, un po’ Beverly Hills 90210 e la sua approssimativa sociologia del privilegio (c’è anche il sosia di Luke Perry, in 13, si chiama Justin, ma non è ricco ed è figlio di una tossica), un po’ Freaks and Geeks e la disintegrazione della società in miniatura che sono le scuole superiori e un po’, soprattutto Donnie Darko e questa idea (nel film fortunatamente allucinatoria, nella serie tentata sul serio) che possiamo controllare quello che succede agli altri, scegliere di implodere per evitare sofferenza agli altri.

L’attore che interpreta Justin e Luke Perry in Beverly Hills 90210. Separati alla nascita.
TeenVogue sostiene sia la serie Netflix più popolare sui social. Su Rivista Studio Silvia Schirinzi spiega che la serie apre alla discussione di temi importanti (per i quali sembra necessario usare termini mutuati dalla cultura americana come bullismo, slut-shaming e bro culture) e ne fa perciò un (circostanziato) plauso. Qui invece vi spieghiamo, in tre punti, perché, secondo noi, la serie racconta i valori di Antonello Venditti con la profondità analitica e la sofisticazione ideologica di una canzone di Antonello Venditti.
’T WASN’T ME
La storia di Hannah Baker è la storia di un delitto. Si apre come qualunque “whodunit” (in italiano “giallo deduttivo”): vediamo quasi subito Hannah morire e la serie è un’indagine per scoprire il colpevole, il responsabile della morte. Salvo che, in questo caso, il delitto è un suicidio e l’indagine è un’indagine morale.
L’implausibile eroe di questa investigazione è Clay Jensen: sfigato, un po’ rachitico, felpa col cappuccio, jeans normcore e un taglio di capelli inqualificabile. Clay è figlio di un professore di lettere in un’università locale (probabilmente un college) e di un’avvocatessa. È innamorato di Hannah, ma non è capace di dichiararsi. Hannah lo chiama “helmet” per via che gira in bici col casco (e forse un po’ anche per l’acconciatura) e a ben guardare la serie è costruita come la storia dell’amore impossibile tra i due (coi classici momenti dei tre atti del plot “boy meets girl”: incontro/scontro > “gaze” (di solito il primo bacio) > luna di miele > incidente/incomprensione > “worst of the worst” > scelta morale > entrambi cambiano > fine).
Hannah lascia, assieme alle cassette, delle istruzioni: vuole che i nastri vengano ascoltati, in ordine, da tutte le persone nominate. Una per cassetta. Clay è l’undicesimo della lista. Riceve i nastri da Tony, suo amico e compagno di scuola, gay ispanico, che farà, per tutta la serie, un po’ da grillo parlante, da angelo custode, accompagnandolo nella faticosa ricostruzione delle tribolazioni che finiranno per uccidere Hannah. Quello di Hannah è a tutti gli effetti un sacrificio. In questo senso si tratta di una storia pseudo-cristiana: la ragazza si sacrifica in remissione dei nostri peccati. Del male che le ha fatto chi (tutti, infine) l’ha portata ad ammazzarsi. Ma si tratta di un cristianesimo disumano, della stessa idea di Cristo che esce dai testi di Venditti, appunto. Un Cristo che impone una ricerca morale priva di sfumature, in cui qualunque cosa deve rientrare in una di due classi: giusto o sbagliato.
È una ricerca che è presentata esplicitamente in questi termini nella serie. Sheri, cheerleader e compagna di Hannah, protagonista di uno dei nastri, mentre studia con Clay al Monet’s, il caffè in cui Hannah incontrava gli amici finché ne ha avuti, nel sesto episodio dice «[…] one of John Grady Cole’s [n.d.r. un cowboy raccontato da Cormac McCarthy] central flaws is his tendency to see the world in black and white, good and evil…». Ed è così che vede il mondo Clay, è così che vediamo noi il mondo di Hannah ed è così che Venditti racconta il proprio panorama morale, in cui alla comprensione profonda del testo che è la vita si sostituiscono delle pedine, in cui «Nietzsche e Marx si davano la mano» perché un fascista e un comunista si salutavano nei corridoi della scuola.
Tutto, in 13, così come in Venditti, è riducibile (e ridotto) alla caricatura della morale. Ed è così che il sacrificio di Hannah, invece che liberarci dai peccati, ci condanna a confrontarci con le nostre imperfezioni, con gli infiniti modi in cui facciamo schifo e ci facciamo del male.
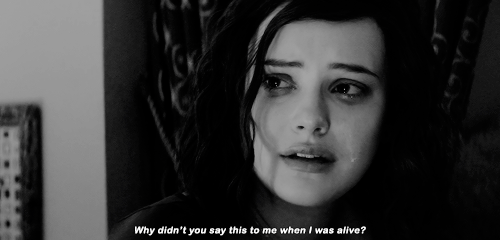
THAT WAS EPIC, BRO!
Il padre di Clay, una specie di antonomasia del liberalismo middle-class americano, nel settimo episodio della serie, dopo aver rievocato le difficoltà nel sopravvivere agli anni del liceo, dice, con qualche ironia, al figlio «I’m a paragon of manhood. With a fucking beautiful family».
Il secondo elemento Vendittiano in 13 è il racconto degli anni dell’adolescenza. Nel presente e nel passato (nel caso del padre di Clay), gli anni dell’educazione sentimentale, della formazione di questi liceali, la vita è durissima, tutti sono sempre pronti a massacrarti, marginalizzarti e, infine, in un senso letterale, ammazzarti. Come se non fossero sufficienti le trasformazioni che ci sfigurano nel fisico a quell’età, l’intolleranza e l’aggressività dei compagni ci rendono la vita, di nuovo letteralmente, impossibile. Questo racconto contribuisce a costruire un’epica dell’adolescenza. Un’epica con due facce: quella comica di Project X, il film in cui l’ennesimo gruppo di sfigati organizza il party del secolo che finisce con esplosioni ed elicotteri della polizia. E l’epica tragica di 13. Perché se l’adolescenza è questo periodo della vita inspiegabilmente difficile allora bisogna affrontarlo con coraggio ed eroismo, renderlo indimenticabile, epico. Per sopravvivere agli anni del liceo è necessario essere forti e la sopravvivenza a questo rito di iniziazione è il marchio del successo. In Venditti la notte prima degli esami è una storia da raccontare per sempre e la fatica che facevamo in quegli anni è giustificata dalle persone che siamo diventati. Persone migliori degli adulti con cui avevamo a che fare (i genitori e i professori), perché non siamo diventati adulti noi. Perché non ci siamo venduti, non siamo finiti a lavorare (non sia mai!) per qualche banca, in qualche (dio ce ne scampi!) ufficio.
Il successo, così, è essere cresciuti senza farsi corrompere, continuando a coltivare il ricordo nostalgico di quelle avventure sapendo che avevamo ragione “noi”. Perché di nuovo, qui, il compasso morale che seguiamo descrive i grandi come “gli altri”, persone incapaci di adeguarsi a un ideale morale irraggiungibile: il nostro. In filigrana, 13 sembra invitare a una forma totalmente irrealistica di perfezionismo morale. Così inverosimile da consumare Clay, che per l’intera stagione deperisce e viene massacrato fisicamente, menato dagli altri e mangiato dal senso di colpa, perché sa di essere su uno dei nastri, ma non sa o non ricorda esattamente cosa ha fatto ad Hannah.
Grazie a Dio l’adolescenza, almeno quella che ci ricordiamo qui, è, in molti casi, molto più prosaica e quasi niente, se non nel nostro racconto esagerato, è ammantato di questo velo retorico, di questo Sturm und Drang. La verità è che mentre cresciamo non succede praticamente niente, siamo chiusi 6 ore al giorno a scuola e viviamo nella speranza che ci capiti qualcosa di memorabile.
Non a caso finiamo per accontentarci di ricordare quelle volte che Mimmo ha sboccato, che Franchino si è cagato addosso, che il Bernasconi si è bruciato i capelli.

SAFE AIN’T SACRED
Venditti è, che lo sappia o meno, il promotore di una forma di libertinismo ingenuo, praticato, prima che teorizzato. Un libertinismo per cui è dovuto il rispetto delle mie idiosincrasie, passioni, ambizioni. Qualunque esse siano. Lo so perché si legge tra le righe di Bomba o non bomba e perché ero presente al concerto suo agli Arcimboldi, qualche anno fa, quando dalla platea si è levata la voce di un abbonato che, dopo due ore e, a essere generosi, 10 canzoni, ha chiesto a Venditti di cantare e «BASTA PARLARE!» Venditti aveva reagito con un gesto signorilissimo tirando fuori una cinquanta euro per rifondere lo spettatore e invitandolo ad andarsene. Perché era intollerabile, per lui, che qualcuno arginasse la sua libertà, la sua verve istrionica.
In un senso rilevante, le intuizioni morali dietro questa discussione sono le stesse del dibattito su trigger warning e safe spaces nei college americani. In una serie di articoli del 2015 l’Atlantic raccontava la deriva discutibile di questa retorica, che aveva progressivamente trasfigurato i luoghi sicuri in luoghi sacri, inviolabili. 13 segue in parte questa deriva e, pur problematizzando senza dare soluzioni, sembra suggerire che ci sia del fondamento nell’illusione di controllo per cui qualunque cosa facciamo è così potente da incrinare per sempre il mondo di qualcun altro. Da romperne l’equilibrio e costringere gli altri a una sofferenza irrimediabile. In questo quadro due passaggi sono illuminanti.
Il primo è ambientato durante la lezione di “comunicazione” (communications class), una lezione che tutti devono seguire per imparare a esprimere le proprie emozioni, uno spazio sicuro nel quale discutere di quelle emozioni e capirle. Una cosa che in Italia ancora non sembra avere attecchito. Durante una di queste sessioni imposte di terapia di gruppo più o meno anonima, un ragazzo risponde alla storia di una compagna sovrappeso che si sente “fat-shamed” dicendole: «Maybe she should try a diet. […] If you’re getting fat-shamed, you know, don’t be fat». Questo è il rovescio della stessa medaglia, l’esplicito ‘blame the victim’ che però ha una presa. In fondo possiamo controllare il modo in cui interagiamo con gli altri, ma è davvero corretto assumere che gli altri non abbiano alcun controllo su loro stessi? Possiamo davvero incaricarci della vita degli altri come se lo stupro e un dispetto o un insulto fossero la stessa cosa. Perché il problema con l’idea di sacralità degli spazi è proprio che qualunque cosa, chiunque è una minaccia se il mio spazio è sacro, se qualsiasi interferenza con quello che voglio fare è una forma di violenza. Se voglio vivere vestito da pinguino, se voglio circolare strisciando per terra la vostra idea di cosa è o non è lecito o anche solo comprensibile è un ostacolo alla mia autorealizzazione.
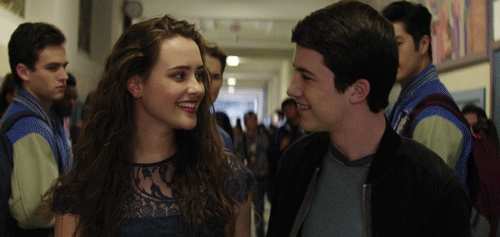
E l’esempio più clamoroso del cortocircuito a cui porta questa prospettiva ideologica è incarnato dal secondo episodio: l’incontro tra Mr. Porter, il consulente psicologico (resident tutti i giorni a scuola, qui in Italia inimmaginabile oggi, credo) e il fotografo che è appena stato sfottuto dai compagni perché è circolata una sua foto coi pantaloni abbassati. I jocks della scuola gli hanno mostrato il culo e lui entra da Porter per lamentarsi e usa l’espressione «They pantsed me». Porter risponde che non sa cosa voglia dire «to pants» e, incalzato, dice «The school I transferred from kids shot kids. Pants I don’t know».
In questo modo estemporaneo viene spalancato l’abisso delle cose non discusse e nemmeno forse tematizzate davvero in 13: le differenze di classe, di razza e di genere, la disuguaglianza.
In 13 l’ideologia liberal mostra come ugualmente urgenti problemi che riguardano la protezione di diritti individuali che si pretendono tutti identici sotto il profilo morale: dal non essere presi per il culo al non essere stuprati. È una sofisticazione ed è, questa sì, moralmente problematica. Perché proteggere una ragazza dalle liste dei culi e delle tette più belle della scuola è un compito improbabile e sicuramente non pressante. Darle degli strumenti per denunciare uno stupro è una cosa essenzialmente diversa e distinguere le due è possibile solo se ci concediamo di ammettere che gli altri esistono indipendentemente da noi, se smettiamo di aspettarci che il mondo assecondi qualunque nostro desiderio. Perché la verità è che chiunque faccia qualcosa che ferisce Hannah, in questa serie, lo fa per opportunismo e, spesso peraltro, in buona fede. E che purtroppo vivere con la responsabilità della vita di chiunque altro conduce a una forma di paralisi che in parte è sintetizzata dalla sequenza finale della serie (che non spoileriamo, ma in cui non succede nulla). In questo senso, il gesto più altruistico che possiamo fare è smettere di assumere che la sofferenza degli altri sia davvero nostra responsabilità. Solo così il sacrificio (davvero cristiano) è gratuito e smette di avere i contorni della condanna.
La nostra guida morale alternativa a Venditti, è Mike Skinner, che in questo pezzo coi The Streets spiega con precisione come e perché rispettare gli altri senza farsi del male e senza cedere al ricatto della responsabilità totale.
Or maybe it’s that I realized that it is true
No one’s really there fighting for you in the last garrison
No one except yourself that is no one except you
You are the one who’s got your back ‘til the last deeds done
Scott can’t have my back ‘til the absolute end
‘Cause he’s got to look out for what over his horizon
He’s gotta make sure he’s not lonely, not broke
It’s enough to worry about keeping his own head aboveThe Streets – Empty Cans













